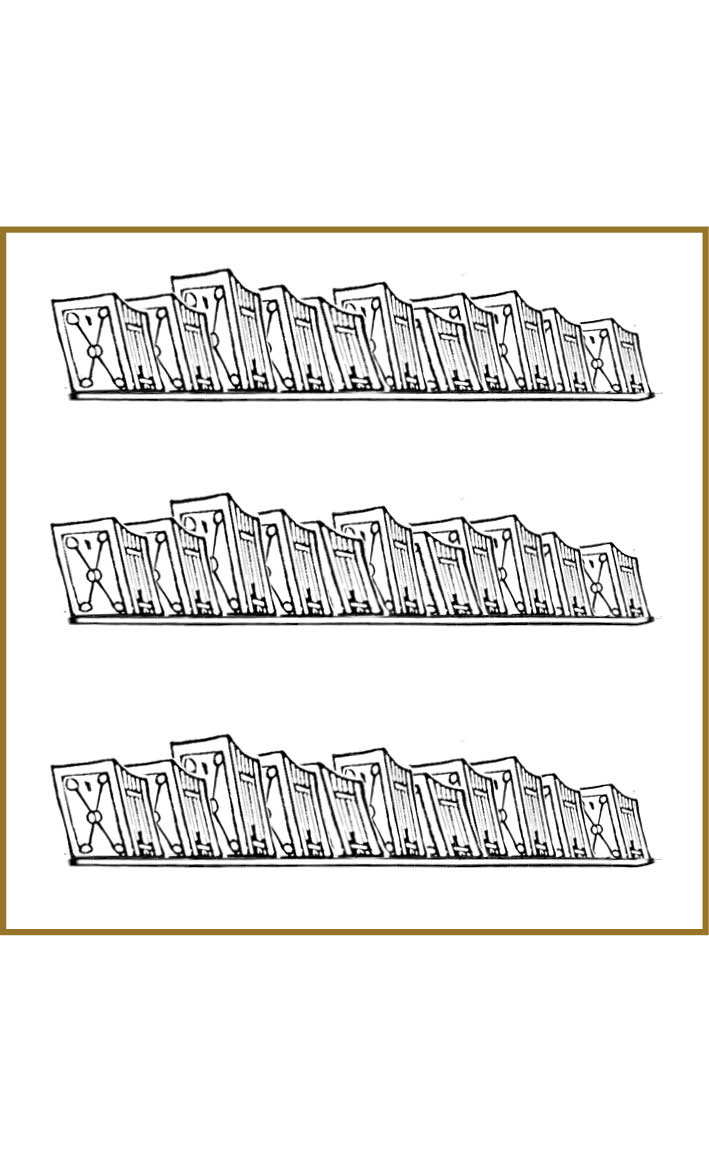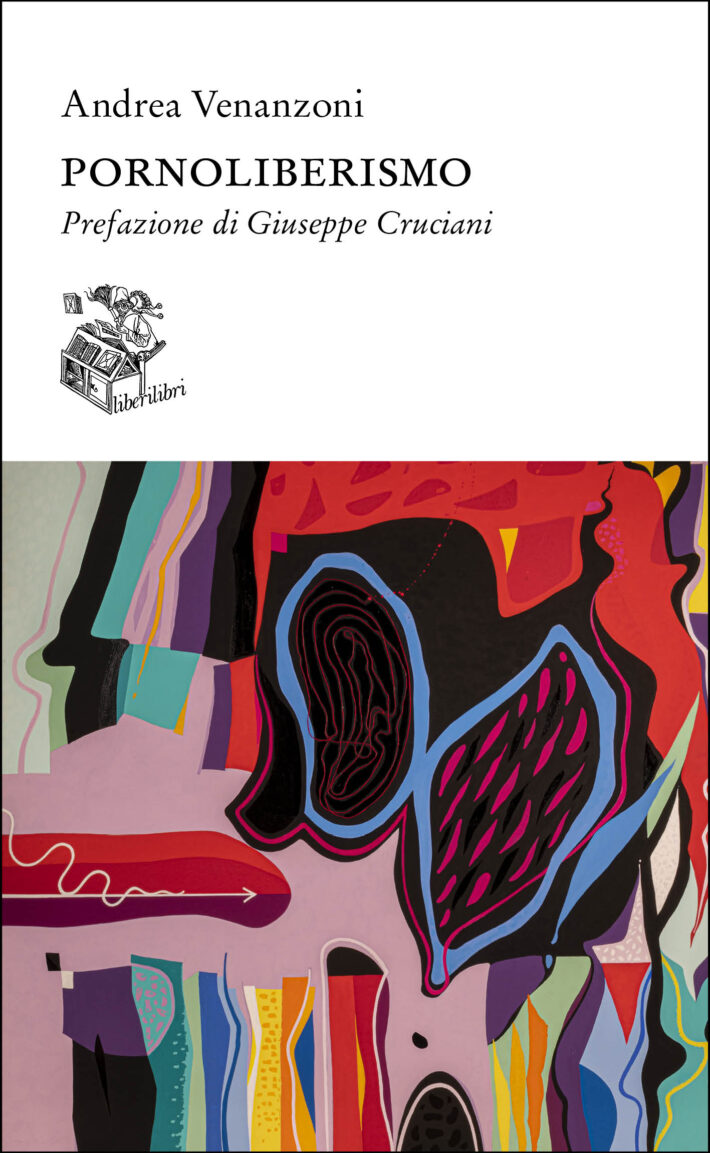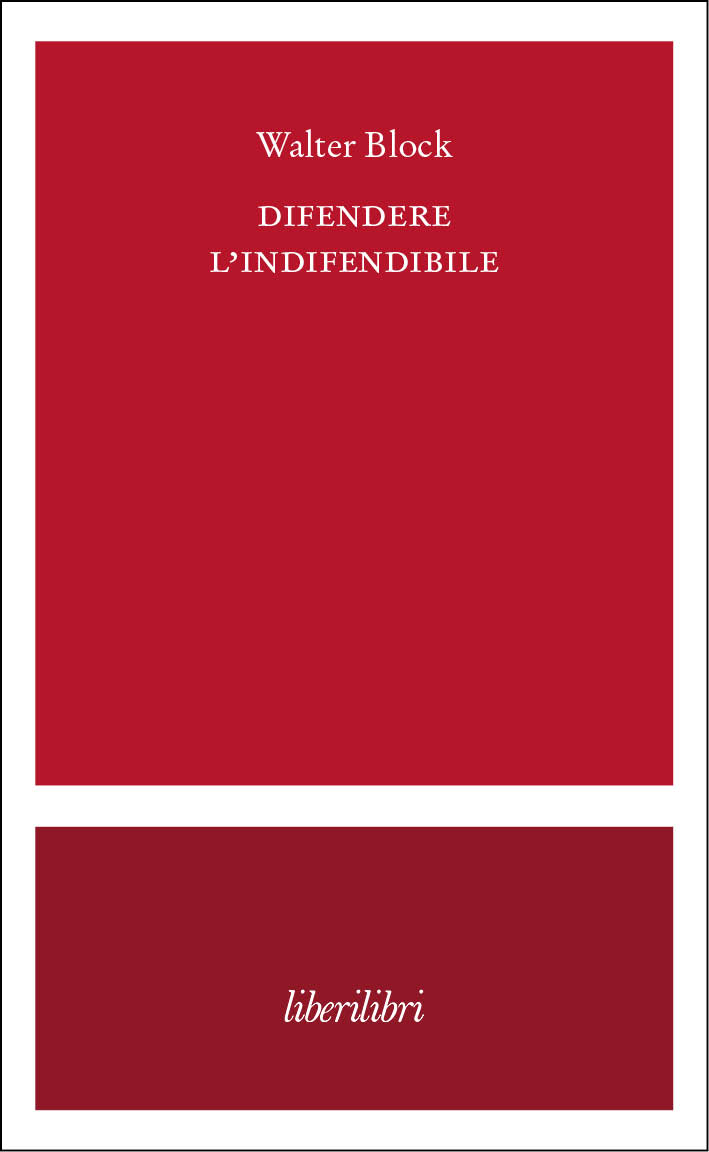Il principio di competenza ha eroso gli spazi e le responsabilità recati dal principio democratico; la tecnica e la politica si sono progressivamente sovrapposte; le comunità sono state spodestate da istituzioni lontane e burocratiche.
Questi cambiamenti hanno intaccato i fondamenti del liberalismo politico, alla base della politica occidentale, aprendo la strada alla tecnodemocrazia in cui si fronteggiano competenza e rappresentanza.
Nonostante il rilievo di tale transizione, la storia della tecnocrazia è rimasta sottotraccia, quasi inesplorata, come ogni arcanum imperii che si rispetti. Oggi, però, si aprono crepe profonde nella legittimità della grande macchina del potere: élites irresponsabili e politiche demagogiche entrano, infatti, in fatale collisione.
L’ingranaggio del potere
Il dominio della tecnodemocrazia nella politica dei nostri tempi.
Pagine 252
ISBN 9788898094714
Prima edizione 2020
17,00 € 11,90 €
La voce dei numeri e il silenzio degli uomini, di Riccardo Manzotti, «Doppiozero», 13 gennaio 2021.
La pandemia del 2020 ha avuto una conseguenza positiva: ha provocato una sorta di risveglio civile e individuale durante il quale problemi di natura etico-morale-politica, che si credevano ormai prerogativa della ricerca accademica, sono tornati protagonisti della discussione pubblica e privata. Giornalisti, scrittori, filosofi, scienziati e frequentatori di social e agorà virtuali hanno scoperto che è inevitabile dibattere sul senso della vita e sui valori in base ai quali si prendono le decisioni sia a livello personale che collettivo. Le grandi domande esistenziali: che cosa ha valore? Qual è lo scopo della politica? Chi decide e perché? Sono nuovamente attuali e non hanno più una risposta obbligata.
Queste domande sono diventate urgenti perché, in conseguenza della pandemia, la società si è trovata a dover scegliere tra valori incommensurabili: salute o libertà, sicurezza o socialità, uguaglianza o economia. E queste alternative sono scelte esistenziali che non possono essere ridotte a calcoli amministrativi. Prima della pandemia, una costellazione di valori condivisi, storicamente assestata e implicitamente accettata dalla comunità dei cittadini, ha consentito di evitare questi dilemmi spinosi per molti anni. Le grandi battaglie su divorzio, aborto, omosessualità erano state combattute e il loro esito più o meno accettato da tutti. La cosa pubblica era diventata, sostanzialmente, un fatto amministrativo e alla politica si chiedeva di fornire amministratori capaci.
In un contesto di relativa tranquillità i cittadini erano caduti in una specie di torpore etico-morale in cui un generico buonismo (chi non vuole essere buono?) consentiva a tutti, senza far nulla, di sentirsi dalla parte migliore della comunità. Il virus, si è visto, ha cambiato tutto questo, ponendo molte persone di fronte a aut aut difficili cui non erano più abituate. Molti si sono resi conto che la vita è scelta e che la scelta non è abbracciare una opzione privilegiata. Questa scomodità etico-epistemica ha costretto molti al confronto di idee come non si vedeva da tempo.
In particolare, l’occhio del ciclone della discussione è stato quello del rapporto tra esperti e cittadini nell’essere protagonisti delle decisioni chiave durante la pandemia: il cittadino è libero di prendere delle decisioni in un momento di emergenza (il famoso stato di eccezione di Agamben) o deve essere messo sotto tutela dal potere politico a sua volta “guidato” dal sapere incarnato dalla comunità scientifica? A questa domanda si è risposto prima con la paura, accettando di fatto una subordinazione dei cittadini al potere politico a sua volta sottomesso al parere di comitati scientifici che, di fatto, lo deresponsabilizzavano.
Un esempio, molto semplice, sarà utile a comprendere la differenza tra valori e sapere scientifico. Il tema è decidere quando sacrificare un valore (per esempio, la libertà di movimento) per difendere un altro valore (la salute). Quando sacrificare il primo con un lockdown indiscriminato per salvare il secondo? In quest’anno passato, troppo spesso la discussione è stata presentata in termini assoluti come se, di fronte alla difesa della vita, non ci fossero margini per decidere. E invece, proprio in questi casi, c’è sempre una decisione libera, implicita o esplicita. Per rendersene conto, consideriamo tre casi ipotetici. Nel primo caso il virus ha un indice di mortalità pari a x. Se x fosse pari al 30%, come nella peste nera del Boccaccio, quasi nessuno vorrebbe rischiare. Nel secondo caso, la mortalità è pari a 0,00001%, come nel caso di alcuni virus minori normalmente endemici. Stavolta nessuno pensa di chiudere le persone in casa. Infine, nel terzo caso, quello reale, l’indice di mortalità x è compreso tra questi due estremi. Per quale percentuale di mortalità scatta la decisione di sacrificare altri valori (movimento, libertà, economia)? Non c’è una soglia implicita nei numeri. Ci possono essere soglie che scattano automaticamente una volta decise, ma le soglie sono il frutto di una decisione: i numeri non parlano da soli.
Questi e altri casi hanno messo molte persone a faccia a faccia con l’irriducibile fondo esistenziale della politica e delle regole accettate dalla collettività. Tre libri in particolare hanno intercettato questa richiesta di senso. […]
Ed è qui che il terzo libro è fondamentale, L’ingranaggio del potere, di Lorenzo Castellani, che si interroga sui meccanismi del potere (Castellani, 2020). Il saggio di Castellani, scorrevole ma completo, dimostra come la democrazia oggi sia debole di fronte alla promessa di un governo tecnocratico dove l’arbitrio delle scelte individuali è sostituito con la presunta competenza di comunità di tecnici.
La decisione individuale (la scelta libera delle persone) non è più vista né come un valore in sé né come l’esercizio di un diritto inalienabile. La scelta personale è solo strumentale al raggiungimento di parametri quantificabili in modo oggettivo attraverso processi decisionali che solo gli esperti possono valutare e formulare. In un mondo sempre più complesso, l’illusione Sette-Ottocentesca della libera determinazione delle persone viene vista come un mito pericoloso, tollerabile quando tutto va bene e completamente irrealistico nei casi di emergenza, come appunto la pandemia.
Secondo Castellani, «la riduzione a un unico parametro apre la strada alla dimensione post ideologica della politica» e, quindi, «se la politica si riduce a competenze tecniche che rincorrono l’unico fine dell’efficienza a che cosa servono spazi e istituzioni di confronto tra opinioni e valori differenti?» L’eliminazione del valore politico dell’opinione personale, non valutata in quanto conforme alle deliberazioni degli esperti, porta all’impoverimento del tessuto sociale su cui è fondata la democrazia e all’eliminazione della cornice valoriale che è necessaria all’esperienza di senso e significato. Già Weber, aveva sottolineato che l’uomo di scienza è incapace di trovare, nel suo operare, i fini che muovono l’essere umano e le idee di libertà, salvezza, felicità «restano estranee alla scienza come professione».
La tecnocrazia non è un’opzione auspicabile, non perché non sia efficiente, ma perché non esprime quell’agire del politico che «tocca sempre il fondo non razionalizzabile della vita umana». In proposito Castellani nota che «la tecnocrazia vede la politica come un problema e non come una soluzione» e questo non è bene, perché la politica è l’espressione del valore irriducibile della persona.
La lotta mortale tra scienza e politica è ben lontana da quel matrimonio felice che viene suggerito dai media. Come nota ancora Castellani «sul piano politico, emergono profonde differenze tra l’antica rappresentanza e quella tecnocratica. La prima trovava il suo centro nel rapporto tra uomo e società, cioè in un rapporto tra uomini con altri uomini; la seconda lo trova in un rapporto tra uomo e conoscenza tecnico-scientifica, che si risolve infine in un rapporto tra competenze tecniche svincolate dell’uomo».
Castellani coglie molto bene il rapporto tra valori e conoscenza, i primi liberi e la seconda invece assoluta. Se il giudizio tecnico sostituisce il giudizio politico, si è compiuto un errore di categorie e «ogni decisione potrà essere soltanto vera o falsa […] il tecnico che pensa di conoscere a fondo un certo argomento mal tollera che le sue tesi incontrino opposizioni e resistenze ed è inevitabilmente tentato di attribuirle all’ignoranza o alla malafede». Credo sia impossibile non riconoscere in queste parole molti degli esperti che hanno riempito i canali televisivi negli ultimi mesi.
In breve, tutti e tre i saggi affrontano il tema del rapporto tra scienza e politica, tra sicurezza e libertà, mostrando i meccanismi che, in questa fase delicata, portano a dare diversa importanza a diversi valori. La pandemia è la declinazione corrente di questa eterna contrapposizione tra valori e acquista un significato diverso se vista in questa prospettiva.
In una società libertaria è importante che l’emergenza non sia una scusa per dimenticare che la democrazia è un fine e non uno strumento. La scelta libera è un diritto e uno spazio irriducibile, non una concessione né un mezzo.
La tecnocrazia è una deriva perché crea un clima culturale in può esservi esistere solo un mono-pensiero, che corrisponde alla conoscenza scientifica, ma che non può esprimere il giudizio di valore, irriducibilmente personale, delle persone. La scienza produce conoscenza, non giudizi. Confondere il piano dei giudizi di valore con quello del sapere è pericoloso perché il primo è esistenziale e irriducibile, mentre il secondo è empiricamente determinato e concettualmente falsificabile.
Durante il 2020, molti cittadini e intellettuali, impauriti dal virus, hanno rinunciato ai loro diritti, sospeso l’esercizio della scelta di opinione, accettato che la politica (che dovrebbe essere l’espressione della loro scelta libera) fosse sottomessa a un potere più grande rappresentato dalla presunta capacità salvifica della scienza. La scienza e la tecnologia, da consiglieri e servi dell’uomo, sono diventate sue padrone. In questo modo si erodono gli spazi della politica in nome di una presunta verità unica, ma, come ha scritto Castellani, «dietro ogni tentativo di annullare la politica come processo di discussione si nasconde un pericolo dispotico».
Insomma, di fronte alla paura per la vita, bisogna evitare di rinunciare ai propri diritti esistenziali e civili. L’antidoto c’è: una politica forte, espressione di una coscienza civile e personale altrettanto forte. Purtroppo per noi, Miconi, Valli e Castellani ci hanno mostrato come la debolezza del tessuto valoriale della società possa, in un caso di emergenza, indebolirsi e lasciare che presunti salvatori si manifestino promettendo di risolvere i problemi che una politica debole non è in grado di affrontare. È un’illusione che andrebbe combattuta, non solo a livello istituzionale e governativo, ma anche personale e individuale.
Come ho scritto sopra, gli esperti non possono sostituire i cittadini. La conoscenza non è mai un giudizio di valore; supporta ma non sostituisce la scelta personale che è un fatto di esistenza e non di calcolo. In ogni decisione si nasconde sempre una scelta: i numeri parlano da soli, ma solo quando gli uomini hanno perso la loro voce.
Come dilagano le tecnostrutture, di Salvatore Santangelo, «Start Magazine», 6 dicembre 2020.
Inserirei certamente l’ultimo libro del politologo Lorenzo Castellani – L’ingranaggio del potere (Liberilibri) – assieme alle Potenze del capitalismo politico di Alessandro Aresu (La nave di Teseo) tra i libri italiani più importanti usciti in questo 2020 funestato dal Covid19.
Castellani evidenzia la dialettica conflittuale tra il principio democratico della rappresentanza e quello tecnocratico della (presunta) competenza. L’analisi prende forma nella cornice di un più ampio approfondimento sulle articolazioni del potere nelle democrazie contemporanee, dove apparati amministrativi, istituzioni contro-maggioritarie (e quindi aree non rappresentative) si sono sviluppate in modo così pervasivo da fare quantomeno dubitare che il potere politico-decisionale appartenga e si esaurisca unicamente all’interno dei processi democratici sotto il controllo quindi dei cittadini e con la loro, per quanto in forma delegata, concreta partecipazione.
Oltre al grande valore scientifico dell’opera, va sottolineato il momento importante in cui irrompe nel dibattito pubblico e questo perché le conseguenze geopandemiche riportano al centro la dimensione dello Stato, l’interventismo in campo economico con il conseguente rafforzamento delle tecnostrutture e articolazioni pubbliche e para-pubbliche. E conseguentemente si evidenzia – nel perimetro pubblico – l’esigenza di riflettere sui criteri di selezione, di retribuzione, di promozione, di misurazione delle performance e dell’efficacia della produzione normativa.
Il saggio ha anche il merito di dare una nuova centralità ad autori come Gaetano Mosca, Carl Schmitt e Ortega Y Gasset: fondamentali per comprendere le “convulsioni” che accompagnano tutti i processi di modernizzazione. E affrontare questi temi diventa anche l’occasione per riscoprire un altro grande pensatore italiano ingiustamente trascurato Bruno Rizzi.
Tra i fondatori – nel 1921 – del Partito Comunista d’Italia, Rizzi non tardò ad accorgersi del mutamento della Rivoluzione bolscevica in una «dittatura burocratica». Espulso per le sue critiche dal PC d’I, Rizzi entra in relazione con Trotzkij, con cui intratterrà una corrispondenza che fornirà alcuni dei materiali per la sua prima opera importante, La Bureaucratisation du Monde, una serrata analisi sulla deriva di ogni regime verso una tecnocrazia e burocrazia universale: opera letta in precisi ambienti culturali apparentemente diversi, da George Orwell a Guy Debord (che lo ha definito «il libro più sconosciuto del secolo»), da Daniel Bell a Guido Ceronetti, da Bettino Craxi a Luciano Pellicani.
Il massimo esponente del trotzkismo americano, James Burnham fu ispirato dall’opera di Rizzi – di cui lesse le bozze in possesso di Trotzki – per il suo saggio di impatto globale: The managerial revolution, sull’emergere – appunto – della tecnocrazia.
Tornando poi alla tensione tra democrazia e tecnocrazia non possiamo non ricordare le riflessioni di Walter Lippmann che – già nel 1922 – annunciava come la natura della democrazia fosse profondamente cambiata; la democrazia in senso “forte” – il governo del popolo, basato sulla sua piena partecipazione alle decisioni politiche – non sarebbe più praticabile: l’opinione pubblica (dal titolo della più importante opera di Lippmann) – emotiva e irrazionale – non sarebbe infatti qualificata a guidare i processi di decisione politica (policy making).
Quindi viene propugnata una mutazione della democrazia in tecnocrazia: per governare efficientemente «il vasto e imprevedibile ambiente» del mondo contemporaneo sarebbero richieste la selezione, la coltivazione e l’educazione di un’élite di esperti e di tecnici che – in quanto detentori non di «opinioni», ma di «una scienza obiettiva» – dovrebbero affiancare i politici nelle proprie scelte.
Comunque, non è possibile parlare di Lippmann senza dar voce alle obiezioni sollevate dal suo più autorevole critico – il filosofo del pragmatismo John Dewey – nel volume The Public and its Problems (1927): proprio la passività del pubblico indotta dal tecnocratismo (benvista da Lippmann) che sottrae al popolo la decisione, provoca nella “gente” i difetti (mediocrità, autoindulgenza, conformismo) imputati alla democrazia. Per Dewey il paradigma democratico come autogoverno del popolo è un valore in sé: «il sano processo democratico è almeno tanto importante quanto il risultato».
La democrazia americana non sarebbe solo un metodo formale, ma l’essenza stessa degli Stati Uniti. Il luogo del dibattito e delle decisioni politiche è il luogo in cui persone diseguali per capacità, reddito, condizioni culturali, si comportano da uguali: sarebbe la cittadinanza a creare l’uguaglianza, non l’uguaglianza a conferire il diritto di cittadinanza.
Dewey contesta inoltre l’idea di Lippmann che l’informazione scientifica esatta renda inutile il dibattito, affermando che – anzi – sono proprio la conversazione, il parlare e l’ascoltare a essere essenziali nella ricerca della verità che serve alle decisioni.
Come si vede, e come ci ricorda Castellani, questo dibattito – avvenuto cento anni fa – mantiene intatte tutta la sua forza e la sua pertinenza in una fase come la nostra in cui la democrazia sta vivendo una difficile transizione. Ernesto Galli Della Loggia ha elencato i sintomi che costituiscono indizio della stanchezza – debole e vile – della democrazia: «La voglia di discutere sulle grandi questioni è sempre più affievolita e assente; sembriamo non avere più idee che ci scaldino, idee o libri che ci dividano, personaggi rappresentativi in cui riconoscerci, spettacoli che ritraggano o segnino gli anni che stiamo vivendo. I conflitti non innescano nessuna grande mobilitazione o riflessione degna di questo nome».
Una stanchezza amplificata da quella che Christopher Lasch ha definito il Tradimento delle élite: le moderne classi dirigenti, da cui dipende il dibattito politico e nelle cui mani si trova il flusso internazionale del denaro e dell’informazione, avrebbero perso il contatto con la gente, sarebbero ormai sempre più cosmopolite e migratorie, sempre meno legate alle collettività che governano. Non si preoccupano della distribuzione di proprietà e ricchezze, né di quella di idee e opinioni che costituiscono i prerequisiti fondamentali per la realizzazione della democrazia. Contro la diffusa sfiducia nei valori dell’Occidente, Lasch ha scritto un’appassionata difesa della libertà intellettuale e dell’impegno a non tradire la democrazia stessa.
Il processo democratico non è un fatto naturale: è un prodotto culturale che, come tale, ha bisogno di costante manutenzione in ragione della sua complessità. La lunga storia della democrazia è lo sforzo millenario di non piegarsi ai poteri di fatto (kràtos e bìa); in questo, forse, sta la chiave per uscire dalla crisi attuale.
La democrazia va sostenuta da virtù civili coltivate da un’energia attiva – per dirla con le parole dello stesso Galli Della Loggia – «politicamente viva ed eticamente pugnace». Anche perché come ammonisce Rizzi, quando sotto la pressione dei processi di burocratizzazione e con l’avvento della tecnocrazia il “mercato” (inteso non solo come sfera economica ma come luogo di scontro/confronto, di “conflitto regolato” tra idee e posizioni politiche) «si estingue, la civiltà regredisce e l’arte, l’economia, l’architettura, la poesia, la politica e ogni altra manifestazione del progresso umano sprofonda negli abissi della barbarie.
Sia che il mercato muoia per cause non previste, come avvenne in seguito alla diffusione della schiavitù nella civiltà antica, sia che muoia per una scelta deliberata rispondente a un preciso disegno politico, come in Urss, gli effetti sono sempre gli stessi: la nascita di una classe parassitaria di burocrati che assume, con la proprietà dei mezzi di produzione, il controllo degli individui».
L’ingranaggio del potere, spiegato senza allegorie, di Guido Vitiello, «Il Foglio», 4 dicembre 2020.
So poco, ahimè, di scienza e filosofia politica, e quando dalla polvere soffocante delle cronache mi vien voglia di ascendere ai cieli puri della teoria, il meglio che so fare è inventarmi delle storielle allegoriche un po’ ingenue di cui uno studioso non potrebbe che ridere. Una di queste è una variazione, o profanazione, del mito platonico del carro e dell’auriga, raccontato nel “Fedro”. Il carro delle nostre società è trainato da una pariglia di cavalli alati, uno bianco e uno nero. Il cavallo nero è il principio democratico, il destriero della volontà popolare, che lasciato a briglia sciolta ci porterebbe a sprofondare nella palude della democratura, ovvero della democrazia illiberale e autoritaria. Perché questo non avvenga, il cavallo bianco del principio tecnocratico trascina il carro nell’altra direzione, ma se ha la meglio nella corsa la nostra destinazione non è molto più felice: è la gabbia della tecnocratura, foss’anche liberale. A impedire l’uno e l’altro scantonamento dovrebbe essere l’auriga, ossia la politica, ma mai come oggi ha avuto i polsi deboli e la vista annebbiata.
C’è da fidarsi? Ovvero la fenomenologia di questa classe dirigente, di Maurizio Guandalini, «Huffington Post», 1 dicembre 2020.
Probatio diabolica. Poteva andare diversamente? C’è da fidarsi? È sottinteso subito dopo. È doveroso chiederselo alla vista del traguardo del vaccino. Il collega Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, in un’intervista a la Verità ci va giù duro: “Abbiamo avuto la classe politica peggiore e raffazzonata nel momento più difficile della storia del nostro paese”. Aggiungo io, oltre la politica anche la sezione “scienze e varie” non è apparsa stupefacente una volta giunta alla ribalta e sotto gli occhi della pubblica opinione, e quindi passibile di giudizio.
Consapevole che è un dettaglio minore, sono corso a leggere i curricula dei politici, ministri, e non, e dei vari comitati scientifici, e non, che tengono le redini del travaglio pandemico. Professori, avvocati, con pubblicazioni, incarichi speciali, soggiorni in istituzioni straniere. Manager, relazioni internazionali, grand commis. Insomma quella che passa sotto il nome di competenza. Di una moderna aristocrazia.
Un melange di tecno-potere di Stato, scienza e capitalismo, lo definirebbe, nel verso negativo, Lorenzo Castellani nel libro, fuorissimo dal coro, “L’ingranaggio del potere”. Allora, qual è il problema? Cosa non va? Oggi, davanti, c’è la fotografia di realtà, tra mille, della politica incapace di scegliere, fin dall’inizio, un nome autorevole per la sanità in Calabria e le incertezze della scienza, a otto mesi dal crack pandemico, ancora lenta nel convergere su un protocollo breve ed efficace di cure da intraprendere a casa, all’insorgere del virus.
E poi, estraggo dal catino pieno d’inciampi, la politica e la scienza insieme che nascondono, stando alle puntuali inchieste giornalistiche di Report, l’ultimo piano di azione dello Stato contro eventuali epidemie, fermo a oltre un decennio fa che spiegherebbe il caos odierno e probabilmente il numero esagerato di morti e, gravità minore, la gestione contraddittoria tra aree rosse, arancioni e gialle tenendo insieme il default sanitario, la necessità di tenere viva l’economia e il venir meno di libertà di movimento che nello stesso istante frenano il ravvio di alcune attività e limitano arbitrariamente, come non mai, la concorrenza.
Per questo è legittimo domandarsi, poteva andare diversamente? E c’è da fidarsi se questa classe politica e se questa classe scientifica sono all’unisono chiamate a gestire la soluzione finale, il vaccino, del male da loro curato con approssimazione e precarietà?
Nell’intricato contenzioso fino a ora descritto manca “il pubblico”. Le persone. Che scelgono e decidono la classe dirigente. La qualità scarsa della classe politica in primis, fino a scendere in tutti settori, è frutto dell’incapacità del cittadino di avere quegli strumenti (in generale, la religiosità del lavoro, stando agli spunti weberiani) che permettono di valutare oggettivamente le competenze e di ritenerle capaci. E quindi, di conseguenza, persone di cui fidarsi.
È vero che ad aggravare l’evolversi degli eventi ci sono gli eventi stessi, inediti, complessi, mai verificatesi con tale intrigo di concause che, a loro volta, sviliscono i parametri consuetudinari di valutazione. Che ci piace rintracciare, pur nella leggerezza del caso, nella ‘fenomenologia’ della trasmissione televisiva di maggior seguito di pubblico, l’Eredità, perché esprime la semplificazione del paradigma classico, il criterio strabico prevalente di valutazione della competenza, veicolato a milioni di persone assurgendo così a senso comune.
Un metodo approssimativo quanto banale, qualunquistico, del sentito dire, sul quale si poggia, nel quotidiano, la nostra scuola (tanto nozionismo, poco sapere, zero imparare un mestiere) e più in generale la scala di valore del merito. Sei laureato, vali. Si pensi da dove è uscito il premier Conte. Avvocato. L’avvocato del popolo. Professore universitario. È bastato che uno sconosciuto, non eletto entrasse alla guida di un paese, lasciando a secco di qualsiasi potere i cittadini di valutarlo ed eventualmente revocarlo. Oggi è perfino complesso, addirittura, accendere un confronto su un eventuale rimpasto di governo.
Ritorniamo al paradigma dell’Eredità. Serve seguirne una puntata. A scelta. Incapperete nelle cantilene del conduttore, ripetute ossessivamente, geni e geniacci perché laureati, professori, avvocati, biologici, e il conduttore, che laureato non è, supino di fronte al supposto sapere dei concorrenti, con il pezzo di carta o in prossimità di averlo, il solo passpartout utile per partecipare al gioco.
Il conduttore non li chiama per nome ma per professioni. Il professore, la biologa, l’avvocato. Sembra di stare nella camera delle corporazioni. Il sentiment non è studiato a tavolino ma nel frattempo siamo certi che quell’idea remissivamente discriminante, di accesso al game-show, esclusiva di colui che sa perché è laureato rispetto a chi laureato non è, passa nell’immaginario del vasto pubblico come metro di giudizio valido verso l’operato delle persone chiamate a risolvere i problemi in ogni settore, a quel tecno-potere di nozioni che i cittadini è ragionevole si affidino. Appieno. Spaventa, qui, l’inpecoronirsi di un popolo proporzionale alla perdita di massa critica. Di orientarsi con il tatto: l’ho sentito pronunciare spesso dal meccanico unto e bisunto di “Affari a quattro ruote” di fronte a problemi solo in apparenza impossibili da risolvere.
Il solo potere, di Niccolò Maria de Vincenti, «l’intellettuale dissidente», 30 novembre 2020.
Nel suo ultimo saggio – L’ingranaggio del potere (Liberilibri, 2020) – il politologo Lorenzo Castellani compie una anamnesi del conflitto tra politica e tecnica, ovvero tra il principio democratico di rappresentanza e quello tecnocratico di competenza. Il potere tecnocratico – definito dall’autore l’altro potere, in realtà unico e solo ad incidere in quest’epoca – affonda le radici sulla certificata competenza tecnica e specialistica degli esperti, senza cioè alcuna legittimazione politica. Un percorso storico secolare ha comportato la supremazia del principio aristocratico (e gerarchico) della competenza sul principio democratico e rappresentativo della politica. Una graduale erosione degli spazi propri dell’autogoverno e della responsabilità è il risultato di una totale abdicazione della politica a favore della competenza, e nella convinzione di aver raggiunto un equilibrio l’attuale assetto ha fuso in unico potere le due forze: la tecnodemocrazia.
La dialettica conflittuale tra kratos e tecnè, osservata innanzitutto come precipitato del rapporto matrimoniale tra lo Stato e il capitalismo, collusione in grado di fornirci spiegazione all’operazione che ha condotto lo sviluppo della grande impresa e la burocratizzazione pubblica a partorire il gigante tecnocratico. All’equazione di razionalizzazione del potere va aggiunta una ulteriore variabile ovvero la scienza ed il progresso tecnologico. L’analisi poggia le basi sull’assunto che le società liberali hanno provato a rispondere alla crescente complessità dei propri meccanismi traslando il baricentro del potere dal politico al tecnico, tentando inoltre di malcelare la permanente contraddizione: ambire all’uguaglianza sostanziale dei cittadini ma ordinarli in un sistema altamente gerarchizzato e basato sul merito.
La progressiva invadenza del potere della competenza basato sulla asserita specializzazione degli esperti ha via via nel corso dei secoli delegittimato il potere politico, esautorando dapprima l’attività legislativa, e l’importanza delle assemblee parlamentari, per poi svuotare di significato anche il potere esecutivo, divenuto mero esecutore di decisioni razionali e scientifiche intraprese in un altrove irresponsabile e non rappresentativo: l’apolide infrastruttura tecnocratica. La ‘rivoluzione silenziosa’ dei competenti si fonda sulla presunzione che all’irrazionalità del dibattito politico può porsi rimedio unicamente con il supporto della tecnica e del metodo scientifico. Depoliticizzare le decisioni e neutralizzare qualsiasi scontro è l’obiettivo primo per la classe tecnica che vede la politica come un problema e non una soluzione. La convivenza di due sfere del potere, politico e tecnico, ha visto soccombere il primo, ormai spossessato dei suoi elementi costitutivi. L’autore non esclude responsabilità della stessa classe politica:
«Nella crescita dello spazio tecnocratico la politica rappresentativa non è affatto esente da colpe. Nello spossessamento del politico vi è certo l’influenza del fattore tecnico, o meglio del tecnicismo crescente dei campi d’intervento dello Stato, ma bisogna fare i conti anche con le debolezze della stessa politica democratica. Sempre più spesso , infatti, la politica è incapace di adottare misure impopolari, di affrontare gruppi di pressione, di selezionare una classe dirigente capace, di realizzare riforme e si riduce ad alienare i propri poteri ai corpi tecnocratici per scaricare altrove le proprie responsabilità. Incapace di prendere una decisione, il politico tenta di mascherare la sua impotenza facendo appello ai competenti.»
“L’ingranaggio del potere” di Lorenzo Castellani, di Luca Picotti, «Pandora Rivista», 24 novembre 2020.
Nel suo ultimo libro, L’ingranaggio del potere, il politologo Lorenzo Castellani si occupa della dialettica conflittuale tra il principio democratico della rappresentanza e quello tecnocratico della competenza. L’analisi si articola nella cornice di un più ampio approfondimento sulle articolazioni del potere nelle democrazie contemporanee, dove aree non rappresentative, apparati amministrativi, istituzioni contro-maggioritarie si sono sviluppate in modo così pervasivo da fare quantomeno dubitare che il potere politico-decisionale appartenga e si esaurisca unicamente all’interno dei processi democratici – sotto il controllo quindi dei cittadini e con la loro, per quanto in forma delegata, concreta partecipazione. Un’analisi più attenta porta infatti a guardare dietro alle quinte, alle spalle dei parlamenti e della politica più in generale, ove si dispiega l’imponente infrastruttura tecnocratica che funge da architrave del potere contemporaneo. Questa si fonda sulla competenza tecnica e specialistica degli individui, selezionati per concorso, titoli o certificazioni e inseriti all’interno di un ingranaggio sempre più complesso che si pone l’obiettivo di amministrare l’esistente sotto una pretesa maschera di neutralità, con decisioni il più efficienti possibili che prescindano dall’intrinseca conflittualità della politica, ma che vadano a guardare al rapporto costi-benefici in funzione del fine ultimo della costante crescita economica e produttiva.
Al principio democratico della rappresentanza si è affiancato quindi, sottraendone sempre maggiori quote di spazio, il principio tecnocratico – o aristocratico – della competenza, di cui non si può più prescindere, sostiene Castellani, in qualsivoglia analisi sulle nostre democrazie. Scrive infatti l’autore: «nelle società avanzate il principio aristocratico ha, nell’organizzazione del potere politico della società, un peso superiore rispetto a quanto comunemente si è portati a credere o ad ammettere. Nelle democrazie contemporanee questo principio aristocratico si fonda sulla competenza, cioè sulla conoscenza specialistica degli individui, fornita e certificata dalla struttura stessa della società attraverso istituzioni educative, programmi di studio, titoli, esami e concorsi. Questo principio aristocratico-gerarchico convive con il principio democratico-rappresentativo di cui, negli ultimi decenni, ha progressivamente eroso significativi spazi. Di conseguenza i poteri non-elettivi, a carattere tecnico, oggi condizionano la vita dei cittadini e le scelte politiche allo stesso modo, se non forse ancor di più, di quelli elettivi e rappresentativi. Per questo ritengo che l’aggiunta del prefisso “tecno” al termine “democrazia” possa aiutare a descrivere meglio la politica del nostro tempo, in cui tecnocrazia e democrazia coesistono dando vita a un regime misto» (p. 25).
L’analisi di Castellani parte dall’assunto che democrazia e tecnocrazia si sono sviluppate all’interno della profonda interazione – sottolineata da diversi studiosi – tra Stato e Capitalismo. La seconda, in particolare, è sorta dall’osmosi tra la burocrazia pubblica e il grande capitalismo, perfezionandosi con l’avvento della società industriale ma avendo già salde le radici nello Stato moderno, che con la sua organizzazione complessa e centralizzata, scandita in norme, regole e procedure, ha favorito lo svilupparsi di quella “calcolabilità” economica e procedurale, nonché, richiamando Max Weber, giuridica, che sta alla base delle infrastrutture tecnocratiche contemporanee. Proprio all’interno di questo “sistema organizzato” si rinvengono, oltre che alcune aporie intrinseche alla democrazia – come l’impossibilità di una uguaglianza sostanziale, dal momento che compiti, redditi e prestigio dei singoli saranno sempre diversi, in uno schema dalle ineliminabili tinte gerarchiche – le fondamenta del principio aristocratico della competenza: vale a dire, legittimazione e modalità d’accesso al potere per istruzione, titoli e qualifiche certificanti determinate competenze specialistiche idonee a servire i diversi livelli del motore burocratico della tecnocrazia.
L’avvento dei tecnici, sempre più numerosi all’interno delle burocrazie pubbliche e influenti nella regolazione della vita dei cittadini, si può considerare, scrive l’autore, come una “rivoluzione silenziosa”, dispiegatasi attraverso la progressiva colonizzazione delle decisioni politiche, in particolare nel secondo dopoguerra, proprio mentre il dibattito tendeva a focalizzarsi unicamente su democrazia e rappresentanza. Oggi, con la convivenza tra democrazia e tecnocrazia che appare palese ai più per svariati motivi – il moltiplicarsi dell’autorità indipendenti di regolazione, il sempre maggiore potere delle Corti, il peso delle Banche centrali, lo spazio che il dibattito pubblico ha riservato alla critica “populista” alle istituzioni non-elettive, il proliferare di comitati e organismi tecnici di consulenza – il punto focale della questione riguarda le linee di confine tra l’ambito democratico e quello tecnocratico. Questo perché, «così come il potere democratico è portato a espandersi oltre confine [l’autore porta l’esempio della scienza, ambito in cui le logiche democratiche non possono trovare applicazione] con una tendenza eguale e contraria, i poteri non maggioritari sono portati ad interferire nella gestione democratica della vita pubblica. Da qui si scatenano conflitti, squilibri e disagi» (p.33).
La conflittualità si registra in particolare nella pretesa di depoliticizzazione delle decisioni da parte dei fautori della tecnocrazia, secondo una logica che ritiene irrazionale affidarsi al lento e farraginoso compromesso democratico per affrontare le sfide di una società sempre più complessa; molto spesso tra l’altro, aggiunge l’autore, è la debolezza della politica stessa, incapace di assumere decisioni coraggiose rispecchianti una certa visione del mondo, a lasciare ampie praterie vuote ai tecnici. Il problema – e da qui parte del disagio che si è iniziato negli ultimi anni a percepire tra i cittadini – è che mentre la politica può essere bene o male sottoposta al controllo da parte degli elettori, la tecnocrazia ne è esente. Questo la porta, unitamente alla complessità delle questioni tecniche cui fa riferimento e agli specifici codici simbolici, culturali e linguistici di cui si fa portatore “l’ordine” (per riprendere la classificazione di Roland Mousnier) costituito dalle élite tecnocratiche, ad essere vista con sospetto, diffidenza, lontananza. Quando poi, solitamente nelle fasi di crisi economica, l’ordine tecnocratico non riesce più a garantire crescita e benessere, nonché a ridurre le incertezze, il sistema di potere si inceppa e si aprono spirali di delegittimazione che vanno a colpire l’intero ingranaggio.
Castellani, per inserire in una cornice di ampio respiro la sua analisi, tratteggia poi una breve storia della tecnica in politica, partendo dalle società idrauliche agro-manageriali delineate dallo storico Karl August Wittfogel per arrivare allo Stato legale ed economico, passando per le città-stato italiane e l’origine dello Stato moderno nella sua veste militare. In particolare, l’autore si sofferma sull’importanza della seconda rivoluzione industriale – una rivoluzione dell’ “organizzazione”, che ha introdotto quella calcolabilità economica e procedurale di cui sopra – sulla formazione delle burocrazie occidentali e i dibattiti negli Stati Uniti (ma anche in Italia e Francia) sulla tecnocrazia come tecnologia del potere per risolvere le crisi degli anni Trenta. Le pagine proseguono con un’analisi dell’opera La rivoluzione manageriale di James Burnham, la discussione di alcuni dati sull’aumento di università e professionisti a partire dalla fine dell’Ottocento, alcuni accenni al processo di integrazione europea – in una stagione in cui si pensava di poter gestire la complessità del reale attraverso la sola apoliticità del diritto privato e dei Trattati europei – e numerosi altri riferimenti, con una densità che non possiamo affrontare in questa sede, volti a chiarire e fotografare il percorso delle società occidentali verso il «Leviatano 3.0».
Tra le riflessioni più interessanti del volume meritano di essere menzionate quelle inerenti al rapporto tra pensiero tecnocratico e nichilismo politico. In queste pagine leggiamo come la missione della tecnocrazia sia «la riduzione della società a un unico criterio di gestione», nell’ottica di una uniformazione del tutto, al fine di attuare una regolare amministrazione dell’esistente priva di qualsivoglia conflitto politico, ideologico o culturale. L’unico parametro decisionale sarebbe quello dell’efficienza, del buon funzionamento dei meccanismi, dal momento che «nella mentalità del tecnocrate non c’è posto per il politeismo dei valori, ma conta soltanto la gabbia d’acciaio della razionalità per amministrare con efficienza». Vengono così spianate le porte ad un nichilismo politico che nella atomistica suddivisione del reale in una indefinita molteplicità di campi singolarmente amministrati secondo il criterio dell’efficienza certifica l’impossibilità del raggiungimento del tutto, cioè l’assenza di un baricentro, di una bussola. Questa assenza, continua Castellani citando il giurista Natalino Irti, si riverbera inoltre in ambito giuridico, con la conseguenza che il diritto diventa “forma”, mera produzione formale di norme, secondo una procedura standardizzata e inserita nella cornice dello Stato come machina machinarum che prescinde dai contenuti e finisce per assumere le vesti di un vero e proprio nichilismo giuridico.
Quello che però il pensiero tecnocratico non riesce a cogliere è che tra la moltitudine di competenze specialistiche non vi è una “competenza delle competenze”, idonea a risolvere i conflitti che sorgono tra queste nel loro continuo intersecarsi e sovrapporsi, e perciò vi è «la decisione che supera le competenze, va oltre». La politica, ci dice Castellani integrando la riflessione con anche una interessante rilettura di Max Weber e Carl Schmitt, riemerge, irriducibile, come esercizio responsabile del potere nelle decisioni ultime circa la vita della polis e per superare hegelianamente la dialettica tra i saperi specialistici, altrimenti irrisolvibile e destinata ad un cortocircuito paralizzante. Questo è un punto fondamentale troppo spesso dimenticato, che ci dice come, anche se volessimo coprire con la maschera neutrale della tecnica ogni decisione, sotto di questa e in merito alle decisioni essenziali ritroveremmo quella politica che si cercava di eliminare.
Il volume di Lorenzo Castellani pone all’attenzione del dibattito pubblico un tema di grande importanza, sicuramente sempre più attuale. Da una prospettiva liberale l’autore suggerisce di prestare particolare attenzione agli entusiasmi tecnocratici, dal momento che dietro ad ogni razionalizzazione dell’esistente, organizzazione burocratica della società, regolazione puntigliosa del vivere associato, possono nascondersi derive dispotiche in grado di incidere negativamente sulle libertà degli individui, trasformando il sistema politico e democratico che conosciamo – sicuramente imperfetto e spesso difficilmente adattabile ai problemi complessi del presente, ma in linea di massima rispettoso delle libertà e dei diritti fondamentali – in una più o meno totalitaria amministrazione tecnocratica della realtà, che dietro alla pretesa neutralità e insindacabilità tecnica delle decisioni annichilirebbe il pluralismo politico. Per questo motivo Castellani, andando anche a rileggere criticamente alcuni autori – tra cui Parag Khanna e Jason Brennan – attratti dalle sirene tecnocratiche, nel riconoscere la ineludibilità della tecnica come motore di società complesse come le nostre, conclude affermando che «nessuna scelta brutale potrebbe risolvere la contraddizione tra principio di competenza e principio democratico. Le società avanzate, se vogliono sopravvivere, devono definire una via intermedia. In altre parole, è necessario conciliare i due principi e i gruppi sociali che ad essi si riconducono, tenere insieme merito e democrazia, gerarchia e legittimazione politica» (p.201). Una sfida non facile, soprattutto se consideriamo che un presupposto fondamentale per affrontarla è quello di avere una politica forte, all’altezza dei tempi, capace di riprendersi gli spazi persi e dialogare con il potere tecnocratico senza subirlo. E una classe dirigente professionale e consapevole del proprio ruolo, senza la quale raggiungere quell’equilibrio sarà, se non impossibile, sicuramente molto difficile.