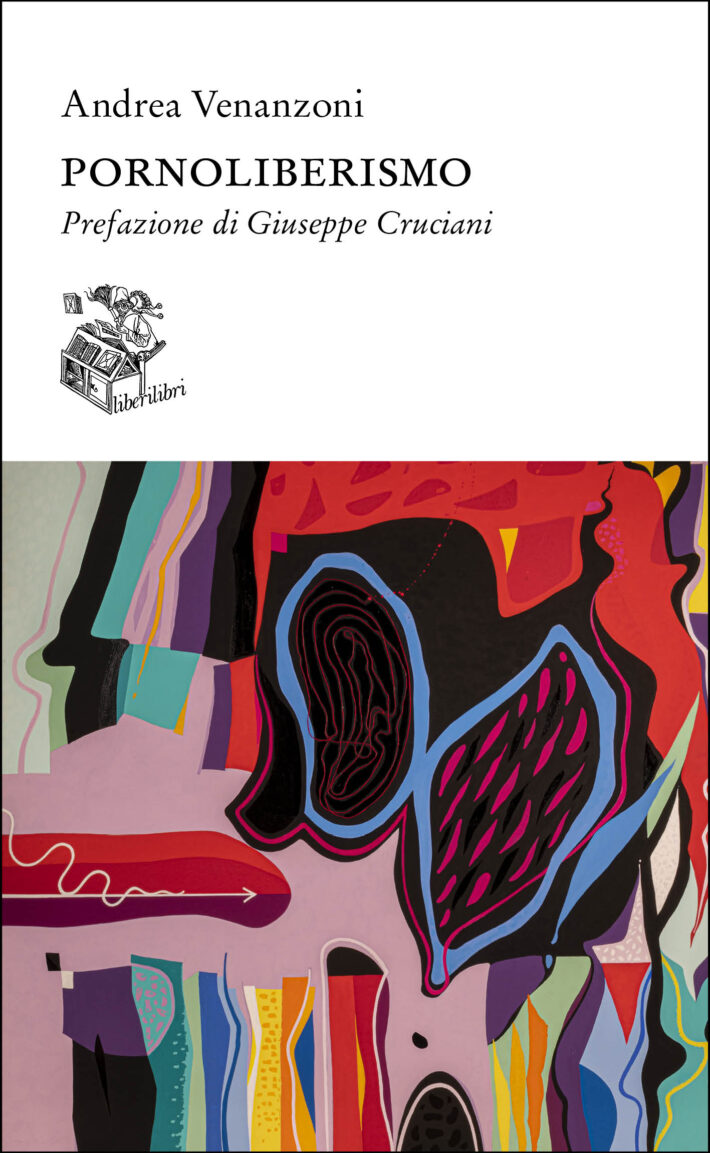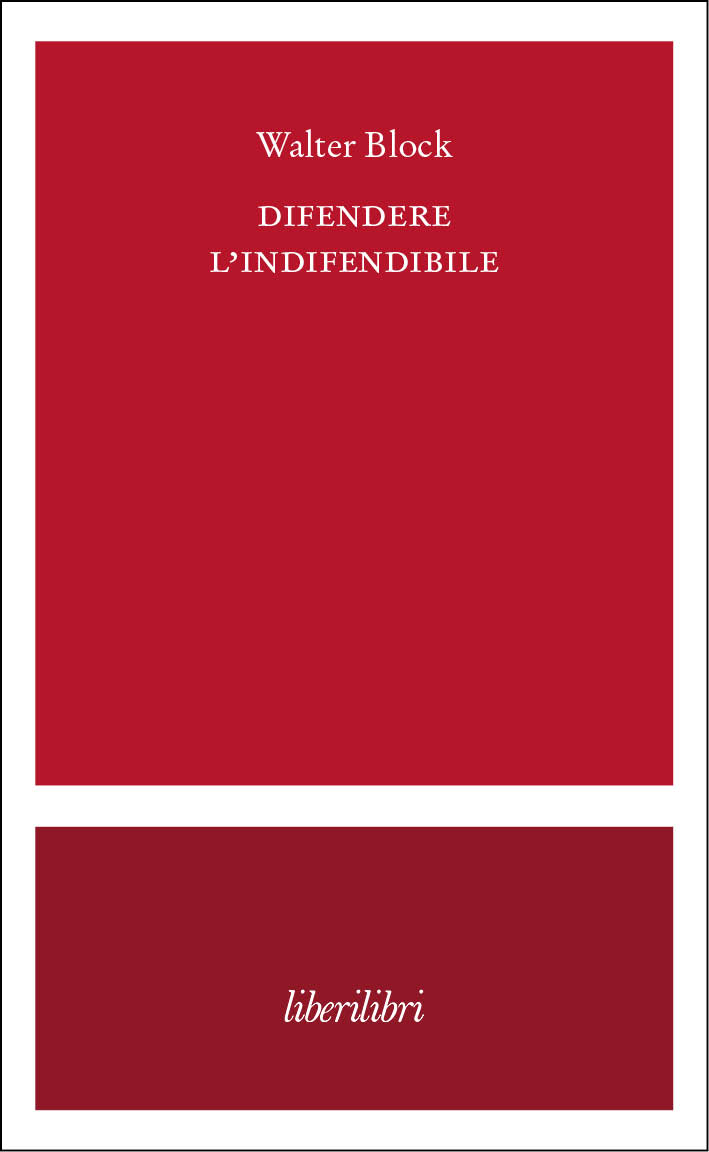Il sogno di creare un paradiso in Terra genera spesso solo inferni. Nel corso della storia, ciò si è verificato, forse più che in ogni altra parte del mondo, in America Latina.
Questo continente vario e straordinario, esotico per eccellenza, lontano per secoli dal “mondo civilizzato”, è un luogo in cui molti esperimenti sociali, economici e politici, basati su utopie nate in Europa, ma maturate laggiù in maniera originale, hanno dato vita a movimenti rivoluzionari con esiti spesso catastrofici.
Non è un caso, tuttavia, che proprio in questo clima magico e irrazionale siano nati molti grandi e amatissimi scrittori contemporanei. Uno di essi è Mario Vargas Llosa che, in questo testo breve e illuminante, analizza le complesse e feconde interazioni tra l’America Latina e l’Europa, e apre alla speranza di un futuro non dominato dall’irrazionalità e dalla violenza, ma all’insegna del realismo e dell’imperio della legge.
Sogno e realtà dell’America Latina
Stereotipi e falsi miti sul continente latinoamericano creati dall’immaginazione europea.
Traduzione di Conzuelo Fogante
Pagine XVI-34
ISBN 9788898094646
Prima edizione 2019
Il prezzo originale era: 10,00 €.9,50 €Il prezzo attuale è: 9,50 €.
M. Vargas Llosa, Sogno e realtà dell’America Latina, di Carlo Marsonet, «Il Pensiero Storico», Gennaio-Giugno 2020, pagg. 1-4.
«Non lo si ripete mai troppo: non c’è niente di più fecondo di meravigliosi risultati dell’arte di essere libero: ma non c’è niente di più duro del tirocinio della libertà», così scriveva Alexis de Tocqueville in quella miniera di perle analitiche e adamantini spunti di riflessione che è La democrazia in America. A distanza di quasi due secoli, infatti, esso rimane uno dei testi più istruttivi per comprendere società, politica e istituzioni del nostro mondo.
Dalla responsabilizzazione richiesta agli individui affinché possano godere della propria vita in libertà, alla dimensione sociale (e politica) della libertà stessa, Tocqueville è in qualche modo presente anche nel libro di Mario Vargas Llosa dedicato all’insorgenza costante e mai domabile della “llamada de la tribu”: Il richiamo della tribù, Einaudi, 2018 (pp. 264, euro 18). Va detto da subito che, per chi ha una certa dimestichezza con il pensiero liberale classico – non chi scrive, evidentemente –, il libro potrebbe risultare una sorta di ripasso del suo percorso durante i secoli. Infatti, si tratta di una biografia intellettuale dell’Autore, il quale da marxista si ritrova, attraverso la lettura e il confronto con alcuni dei più importanti pensatori dell’alveo liberale, ad attraversare un tragitto per così dire di resipiscenza. Infatti, sin dalla prima pagina il premio Nobel per la letteratura (vinto nel 2010) specifica che si tratta di un travaglio lungo (e doloroso), maturato sul campo.
Nato nel 1936 in Perù, «mi allontanarono da marxismo diverse esperienze di fine anni Sessanta: la creazione delle Umap a Cuba, eufemismo che dietro la facciata di Unità militari di aiuto alla produzione nascondevano campi di concentramento che mescolavano controrivoluzionari, omosessuali e delinquenti. Il viaggio in Urss, nel 1968, dove ero stato invitato a una commemorazione di Puškin – prosegue Vargas Llosa – mi lasciò l’amaro in bocca. In quell’occasione scoprii che, se fossi stato russo, sarei stato un dissidente (ossia un paria) o sarei marcito nei Gulag. Rimasi quasi traumatizzato. Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty e “Les Temps Modernes” mi avevano convinto che, al di là dei problemi che potevano esserci, l’Urss rappresentava il progresso e il futuro, la patria dove, come diceva Paul Eluard in una poesia che sapevo a memoria, “Non esistono puttane, ladri né preti”. In compenso – continua l’Autore – la povertà, gli ubriachi riversi sulle strade e l’apatia generalizzata esistevano eccome; si percepiva ovunque una claustrofobia collettiva per la mancanza di notizie su ciò che accadeva lì e nel resto del mondo. Bastava guardarsi intorno per capire che, pur essendo sparite le differenze di classe legate al denaro, in Urss le disuguaglianze rimanevano enormi, e legate esclusivamente al potere» (p.7). La citazione è lunga, ma necessaria a inquadrare l’illusione di chi credeva in un mondo migliore, più solidale e più umano, filtrato dalle parole di quegli intellettuali che, per primi, furono “abbagliati” dal mito della Rivoluzione. All’incanto mentale, tuttavia, seguì quell’amara presa d’atto che le parole altro non erano che mera immaginazione, la proiezione nel reale dell’ideale. Proprio a quest’obnubilamento, com’è noto, Raymond Aron ha dedicato forse le pagine più intense e brillanti ne L’oppio degli intellettuali, in cui si può leggere ciò che segue: «Il concetto di rivoluzione, come il concetto di sinistra, non cadrà mai in disuso. Esprime anch’esso una nostalgia che durerà fin quando le società saranno imperfette e gli uomini smaniosi di riformarle. […]. Tutti i sistemi conosciuti sono condannabili se li si paragona a un ideale astratto di uguaglianza o di libertà. Solo la rivoluzione, poiché è un’avventura, o un regime rivoluzionario, poiché consente l’uso permanente della violenza, sembrano capaci di raggiungere il fine ultimo. Il mito della rivoluzione serve da rifugio al pensiero utopistico, diventa il legame misterioso, imprevedibile, tra il reale e l’ideale» (L’oppio degli intellettuali, trad. it., Lindau, 2008, p. 99).
Non è un caso che proprio Aron sia uno dei sette autori cui Vargas Llosa deve il suo ravvedimento intellettuale e a cui dedica uno dei “medaglioni” presenti nel libro (gli altri sono Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin e Jean-François Revel). La linea invisibile che unisce il volume è quella della responsabilità che lega l’individuo alla libertà. Senza di essa, la libertà viene perduta. E tale responsabilità si manifesta in diversi modi, ma, forse prima di tutto, in quel sano scetticismo che unisce i tre autori cui l’Autore deve di più, come afferma egli stesso (p. 80): Hayek, Popper e Berlin.
Il primo, che qualcuno giunge addirittura a definire un autore “monistico” per la sua idolatria del mercato, è consapevole di quella ineluttabile e irredimibile ignoranza che attanaglia la condizione umana e che non può essere assolutamente vinta. Nondimeno, l’unico modo per cercare di combatterla è quello di affidarsi a un processo – non una realtà di per sé esistente, pensante e statica – che mette in comunicazione miriadi di individui, ciascuno dotato di propri mezzi – materiali e, soprattutto, informativi – e obiettivi differenti. Tutt’altro, dunque, che uno strumento infallibile e perfetto, ma, semmai, l’unico modo (imperfettamente) efficace che può far fronte a quell’insopprimibile ignoranza che qualcuno ha la “presunzione fatale” di poter schiacciare. Lo spirito scettico hayekiano, pertanto, ben si congiunge con lo spirito critico di Karl Popper il quale ha messo in guardia dall’idolatrare la scienza (proprio come, a suo modo, Hayek fa con il mercato): «La scienza non posa su un solido strato di roccia. L’ardita struttura delle sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un edificio costruito su palafitte» (Logica della scoperta scientifica, 1934, cit. a p. 130; corsivo mio). E proprio questo spirito fortemente ispirato alla titubanza e al vacillamento nei confronti del sapere umano, che mai arriverà a verità ultime, ha portato a dire Berlin che «mi annoia leggere degli alleati, delle persone che la pensano più o meno come me […] È molto più interessante leggere i nemici, perché i nemici penetrano nelle difese e trovano i punti deboli. A me interessa scoprire quali errori contengono le idee in cui credo, perché è giusto cambiarle o persino abbandonarle» (Tra filosofia e storia delle idee. La società pluralistica e i suoi nemici, cit. a p. 227).
Proprio quando viene meno una visione scettica o critica delle faccende umane, dunque, la società aperta è insidiata. Un’insidia che, come abbiamo detto, può venire da quella Hayek definì “abuso della ragione”, ma, al contempo, da un “abuso dell’immaginazione”. È questo il caso che ha visto e, in parte, continua a vedere come principale punto di riferimento l’America Latina. A tale questione, ben collegata peraltro a quanto si è detto finora, è giunto lo stesso Vargas Llosa con l’agile saggio che Liberilibri di Macerata ha da poco tradotto: Sogno e realtà dell’America Latina (pp. 33, euro 10, con introduzione di Carlo Nordio).
Se l’Urss ha destato un certo interesse velato di ideologia da parte degli intellettuali marxisti, altrettanto si può dire nei confronti del continente latino-americano. Sennonché, la fantasia dell’immaginazione per tale continente, come sottolinea l’Autore, viene ben più da lontano, e precisamente fin dalla sua scoperta medesima. A partire da quel lontano 1492, infatti, l’America non ha fatto altro che «materializzare le loro [degli europei] fantasie religiose e ideologiche, incarnando i paradisi a cui anelano o gli inferni che li spaventano» (p. 11). Prendendo a riferimento un caso specifico, quello di Günter Grass, Vargas Llosa si chiede: «Perché uno come lui, che in Germania faceva campagna per la socialdemocrazia e criticava i comunisti, chiedeva che i latinoamericani seguissero “l’esempio di Cuba”? Perché quello che è un male per gli europei è un bene per i latinoamericani? La ragione è molto semplice – si risponde da sé il premio Nobel – : perché per Günter Grass […] l’America Latina, più che una realtà concreta, è una realtà fittizia nella quale riversare le proprie utopie fallite e con la quale rifarsi delle loro delusioni politiche» (p. 15).
Insomma, la proiezione del desiderio frustrato dalla realtà in un luogo verso un altro, oltre che un’operazione puerile, è prima di tutto estremamente pericoloso. Fingendo di non vedere, accecati dal mito e dall’immaginazione, il rischio è quello di distruggere la realtà stessa, e quindi, tra l’altro, le persone in carne e ossa. Come sostiene Vargas Llosa, un conto è l’immaginazione nella letteratura, nell’arte, nelle discipline artistiche che da questa vengono arricchite. Un’altra questione, invece, è il suo utilizzo nella dimensione politica e sociale, nella quale, al contrario non si può che affidarsi a un duro ma sano realismo.
Questa è l’esortazione conclusiva del premio Nobel: «Rinunciare all’impossibile e ai canti delle sirene dell’irrealtà, utili e appetitosi per i costruttori di finzioni, ma nefasti per chi invece si dedica alla dura missione di vincere l’ignoranza, la fame, lo sfruttamento e la povertà, per creare un mondo senza dispotismo, di giustizia e libertà, con uguali opportunità per tutti, dove la felicità non si raggiunga soltanto chiudendo gli occhi di fronte alla realtà circostante e rifugiandosi nel sogno e nell’immaginazione, ma anche talvolta, nella vita vera» (p. 33). Come scrive Raymond Boudon, «il liberalismo rappresenta la tradizione di pensiero meno escatologica che vi possa essere» e ciò «lo rende poco attraente per molte persone» (Perché gli intellettuali non amano il liberalismo, trad. it., Rubbettino 2004, p. 66). Ma proprio perché non è una teoria “chiavi in mano”, essa può far maturare quella necessaria responsabilità senza la quale la società aperta e la libertà non possono sopravvivere. Dopo tutto, essere adulti non significa forse sobbarcarsi di molteplici, gravosi oneri?
Malintesi e malafede. Ecco l’America Latina della sinistra onirica europea, di Marco Archetti, «Il Foglio», 14 febbraio 2020, pag. 2.
Anatomia di una malafede. “Sogno e realtà dell’America Latina” (33 pp., 10 euro), breve e accuratissimo saggio di Mario Vargas Llosa pubblicato per i tipi della casa editrice Liberilibri, è veloce come un colpo di sciabola a braccio teso e altrettanto efficace nel trafiggere, inchiodandoli alla propria contraddizione, tutti gli equivoci e le vacuità tipiche di chi ha preteso, nella storia del lungo rapporto tra Europa e America latina – nella storia del loro legame culturale inscindibile – di vedere quello che non c’era, e per scellerata conseguenza, in nome di questa cecità creativa (i più romantici parlerebbero di abbaglio), di straparlare e straparlare, partorendo mostri teorici di mitopoiesi immaginifiche, allegorie spacciate per tesi razionali e giganti di proiezioni assurde. E’ la storia tristanzuola dell’arcinota sinistra latinoamericanista a priori, quella convinta che in quel continente presuntamente magico fosse praticabile anche la magia di un marxismo rural-ecumenico di matrice fanta-letteraria in grado di coniugare istanze diverse, culture diverse e storie diverse, non già viste come tali, ma al contrario, uniformate secondo i propri puerili e feroci criteri-pialla. E’ l’eterno frutto avvelenato di quel che Vargas Llosa chiama “ricamo utopico”, codice preponderante con cui la cultura occidentale si è rapportata al continente americano. “Questo ha tracciato il destino dell’America latina: l’essere percepita dagli europei con gli stessi occhi fantasticanti con la quale la videro i primi navigatori che misero piede sul suo suolo”. E infatti Cristoforo Colombo – giova ricordarlo, e Vargas Llosa lo ricorda – scoprì un continente nel quale si sforzò di vedere non quello che era davanti ai suoi occhi ma quell’Asia della seta e delle spezie che recava con sé nel proprio desiderio e nella propria immaginazione. Il libro è un atto d’accusa scritto con arguzia e levità, senza mai rancore ma soprattutto senza sconti verso la sinistra onirica europea, quella che a dispetto della realtà e delle sue sfumature, a dispetto della complessità e delle sue implicazioni, con tutti i suoi segnacoli e i suoi tintinnaboli ha cantato Messe la cui eco stenta tutt’oggi a scemare, e che vanta, tra i suoi più fanatici e biliari sacerdoti, una maggioranza di canuti ossessivi che inneggiano al Castro-madurismo brandendo tutti i testi rivelati del Realismo magico, nostalgici di ciò che hanno vissuto gli altri e incapaci di comprendere che letteratura e politica battono strade completamente diverse. Diciamolo: è il Vargas Llosa più schiettamente popperiano quello che da queste righe ci invita a un rapporto razionale con i fenomeni sociali ed economici (lo sintetizza Nordio nell’introduzione: “Meno deliri e più sensatezza!”), al punto che la lista delle persone cui verrebbe voglia di regalare questo testo – salutare e squisita lezione sul rapporto tra cultura, politica e realtà – sarebbe infinita. Ma è infinito anche il novero dei guerrilleros da tastiera che imperversano sui social trombettando ricette infallibili solo per loro (spesso fallite in tutto il resto del mondo), infiniti i cinici travestiti da romantici che tifano per la dittatura che sconterà sempre qualcun altro e che viaggiano in direzione ostinata e contraria sì, ma rispetto al comune senso del decoro intellettuale.
Il libro di Mario Vargas Llosa è scritto con grande eleganza. Qua e là lampeggiano bagliori e le pagine sono impreziosite da alcune piccole intuizioni lessicali e da certi ritratti fulminei ed essenziali: si veda la parte su Régis Debray e il suo “¿Revolución en la Revolución?” testo di riferimento del catechismo delirante internazionale pubblicato nel 1967, o la stoccata allo scrittore Günter Grass, socialdemocratico in patria e barbudo in politica estera. La conclusione è esemplare: tutti coloro che, non tenendo conto delle infinite frammentarietà di un continente complessissimo e di una cultura che è tale proprio perché non ha né radici né carattere univoco, vogliano proiettare lì utopie fallite nel proprio, sono simili ai tanto vituperati colonizzatori. Che siano armati di immaginario letterario, poco cambia: spesso ha prodotto gli stessi danni di un esercito.
SOGNO E REALTÀ DELL’AMERICA LATINA, di Pietro Di Muccio de Quattro, «l’Opinione», 29 gennaio 2020.
Non siamo del tutto d’accordo con Carlo Nordio, autore della meditata introduzione, il quale nel saggio di Vargas Llosa (“Sogno e realtà dell’America Latina”, Liberilibri, Macerata, pag. 33, euro 10) trova che “il pregio straordinario di questo breve saggio risiede nell’aver dissolto alcuni luoghi comuni sull’America Latina”.
Certo, Vargas Llosa contribuisce anche a questo, da par suo. Ma noi scorgiamo in questo acuto saggio, del quale diamo per scontato lo stile brillante del premio Nobel riconosciuto, la riproposizione dei valori occidentali in un’eloquente forma letteraria, con specifico riferimento alla realtà sudamericana. Il grande scrittore, “convertitosi al liberalismo dopo l’insoddisfacente esperienza marxiana” (come fa notare Nordio), evidenzia la profonda aporia del Sud America mettendo a confronto il fallimento della politica con la fioritura delle arti: fallimento e fioritura che in verità sono sotto gli occhi di tutti coloro che usano tenerli aperti. Fanno eccezione gli epigoni del rivoluzionarismo comunista, ciechi entusiasti delle dittature e dei dittatori, al potere o aspiranti, come Castro, Chávez, Marcos, in una condizione in cui “la politica, con poche eccezioni, rimaneva ancorata a un passato di ‘caudillos’ e ‘camarillas’ che esercitavano dispotismo, saccheggiavano risorse pubbliche e tenevano l’attività economica congelata nel feudalesimo e nel mercantilismo”.
Vargas Llosa manifesta una visione illuministica nella variante genuinamente liberale del razionalismo critico e del realismo politico. Premesso che “confondere la realtà con l’immaginazione ha sempre avuto conseguenze tragiche per l’umanità”, egli afferma: “In ambito politico, nel quale, a differenza di ciò che accade in quello artistico e letterario, è bene discernere con chiarezza ciò che divide la realtà dalla finzione, tale tendenza è risultata essere dannosa e, a volte, catastrofica”. Il suo appello alla ragione è esplicito quanto appassionato: “Facciamo uno sforzo di razionalità, proviamo ad avvicinarci – con la consapevolezza che ciò è molto difficile, poiché tutti noi latinoamericani, che lo vogliamo o no, siamo infettati di mitologia e di utopismo – alla realtà che giace sotto la fosforescenza di immagini con le quali l’ideologia, la religione e la letteratura hanno rivestito l’America Latina.”
Il cuore pulsante del saggio sta nel chiarire, in modo inequivocabile ed esaustivo, l’antinomia (spesso non considerata né investigata) intrinseca alla stessa cultura latinoamericana, cioè “la contraddizione che esiste tra la sua realtà sociale e politica e la sua produzione letteraria e artistica”. La prima è “l’incarnazione stessa del sottosviluppo”; la seconda “detiene un alto coefficiente di originalità letteraria ed artistica”.
Vargas Llosa ricorda di aver discusso tale paradosso con Günter Grass. Pur considerandone “eccellente” il romanzo “Il tamburo di latta”, giudica tuttavia lo scrittore tedesco “meno lucido riguardo alle sue ricette politiche per l’America Latina” dal momento che, mentre in Germania faceva campagna per la socialdemocrazia e criticava i comunisti, chiedeva poi sorprendentemente che i latinoamericani seguissero “l’esempio di Cuba”. E pone a sé e a noi la domanda cruciale: “Perché quello che è un male per gli europei è un bene per i latinoamericani?”. La ragione appare semplice a lui quanto sorprendente a noi. Günter Grass, non meno di Régis Debray, Sartre e altri come loro pure in Italia, vedono nell’America Latina, più che una realtà concreta, “una realtà fittizia nella quale riversare le proprie utopie fallite e con la quale rifarsi delle loro delusioni politiche”.
Vargas Llosa insiste sul “divorzio” tra cultura e politica, sebbene non senza una certa qual incoerenza perché è inevitabile che la seconda permei la prima e viceversa. Tuttavia l’incoerenza appare piuttosto ridotta che sostanziale, come egli ben spiega in questo passo: “Mentre le nicchie della vita culturale – spazi di libertà svincolati, per loro fortuna, da un potere politico generalmente sprezzante della cultura – venivano in contatto con la modernità, progredivano e ne nascevano scrittori ed artisti di alto livello, il resto della società rimaneva poco meno che immobilizzato in un anacronismo autodistruttivo”.
Le utopie terzomondiste e le tentazioni collettiviste hanno allontanato il Sudamerica dall’ideale di “società moderna composta di uomini liberi, vale a dire diversi tra loro, che possono manifestare le loro differenze di fronte agli altri, senza che questo sopprima la solidarietà dell’insieme”.
L’America Latina ha necessità di trasferire nell’ambito politico e sociale la libertà conquistata nel campo artistico, letterario, musicale e cinematografico. “Meno deliri e più sensatezza e razionalità per creare un mondo senza dispotismo, di giustizia e di libertà, con uguali libertà per tutti, dove la felicità non si raggiunga soltanto chiudendo gli occhi di fronte alla realtà circostante e rifugiandosi nel sogno e nell’immaginazione, ma anche, talvolta, nella vita vera”.
Vargas Llosa dovrebbe far meditare soprattutto gl’ideologi italiani della “placenta tribale”, ostili alla società formata da individui indipendenti e responsabili anziché drogati di abalietà. Sebbene scritto nel 2008, chi può dire che questo saggio sia inattuale?
Vargas Llosa: l’America Latina? Non esiste, è un “sogno” degli europei, di Alberto Mingardi, «Tuttolibri La Stampa», 18 gennaio 2020, pag. 21.
L’America Latina è quel luogo dove si preferisce sistematicamente la leggenda alla storia. La tendenza europea a proiettarvi «i sogni dell’immaginazione, la religione e la mitologia» risale a Cristoforo Colombo, che per primo «si sforzò di vedere non quello che era davanti ai suoi occhi e sotto ai suoi piedi, ma l’India e la Cina, l’Asia della seta e delle spezie che portava con sé nel suo desiderio». Il continente finisce per sovrapporsi sempre più non ad altri luoghi, alle terre del desiderio degli europei, quanto invece aì non-luoghi dell’immaginazione politica: in particolare, a una sorta di utopia roussoviana, a uno stato di natura dove l’uomo nato libero non conosce le catene della proprietà privata né le lusinghe del progresso materiale.
Come ogni mito, anche questo affonda le radici in una realtà: quel senso di «reale meraviglioso», che si trova in una «terra dove il mito non si era congelato nelle biblioteche ma, anzi, palpitava nelle sue piazze e nei suoi villaggi, nelle sue danze e soprattutto nella sua gente e nei suoi avvenimenti sociali».
Il guaio è che a furia di scriverli e leggerli, certi racconti, si finisce per crederci. Chi racconta una favola crede alle proprie parole, chi ne è protagonista confonde la fiaba con la sua vita. E’ così che le utopie bussano alla porta della storia e chiedono di essere «realizzate». Contro quest’eterna maledizione di narratori e narrati Mario Vargas Llosa ha scritto trenta auree pagine, ora tradotte in italiano da Liberilibri con prefazione di Carlo Nordio. Il titolo è Sogno e realtà dell’America Latina e il libro è per l’appunto una difesa della seconda dal primo. Imperfetta e miseranda, ma perfettibile e viva, la realtà latinoamericana è altra cosa dalla «fosforescenza di immagini con le quali l’ideologia» l’ha rivestita. Si pensi alla madre di tutte le questioni latinoamericane: la querelle fra ispanisti, per cui la storia del continente ha inizio con l’arrivo di spagnoli e portoghesi, e indigenisti, secondo cui la realtà genuina del Sud America risiede nelle civiltà pre-ispaniche e nei suoi discendenti, i popoli indigeni.
Questi ultimi coltivano una retorica in cui la guerra di classe scivola nella guerra di razze e il sogno della sollevazione degli oppressi contro i padroni s’incarna nella ricerca di un messia con tratti somatici inconfondibili. Come Evo Morales, acclamato dalla stampa internazionale come il primo indio a essersi seduto sullo scranno più alto quando in realtà la storia ricorda «una considerevole raccolta di dittatori e tirannelli, fra i quali vi erano vari indios aymara e quechua, che presero il comando dello Stato boliviano».
Prima ancora che dare risposte precotte, l’ideologia induce a farsi le domande sbagliate. Vargas Llosa cita Euclides da Cunha, autore del primo libro sulla «guerra di Canudos», le quattro spedizioni punitive dell’esercito brasiliano contro gli insorti dell’insediamento di Canudos, nello Stato di Bahia, che rifiutavano l’autorità della neonata Repubblica Brasiliana in ragione della predicazione di una sorta di profeta, Antônio Conselheiro. Il buon Euclides si avvalse «di tutte le teorie sociologiche imperanti nell’Europa del suo tempo». Ma l’impasto di miseria e fede dei rivoltosi di Canudos non si poteva spiegare con gli schemi concettuali europei, come poi proprio Vargas Llosa dimostrerà, con La guerra della fine del mondo. In quel libro, un aspirante rivoluzionario di professione, Galileo Gall, punta su Canudos sperando di trovarvi un esperimento di comunità socialista. I ribelli coltivano semmai la nostalgia del vecchio Impero, la cui immagine, sfocata come sono tutte le cose alla periferia del mondo, diventa un tassello sfasato ma importante nello sghembo mosaico della loro fede.
I sogni semplificano, la realtà è sempre più complicata. La prima e più grave delle semplificazioni è attribuire «all’America Latina un’unità che non ha – quella dell’omogeneità culturale – e ne ignora la dispersione o la varietà sulle quali risiede il suo denominatore comune».
Se la civiltà è plurale, contraddittoria, piena di biforcazioni, il primitivismo indica sempre un’origine unica, omogenea, un mondo nel quale non esistevano differenze, in cui l’identità di tutti era perfettamente sovrapponibile e, dunque, nessuno conosceva l’invidia. Per Vargas Llosa l’America Latina è un
«prolungamento ultramarino dell’Occidente» proprio perché è contraddittoria e plurale, sortita da un’infinità di incontri e scambi fortuiti. Ma questo significa interrogarsi sulle identità, non sognarle. E chi le sogna è capace di sognarne una alla volta. Le tragedie del continente verrebbero dall’incapacità di essere «un» popolo, solidale e forte nell’unità, privo di fastidiose differenze. E’ una visione parente stretta di quel nazionalismo per cui «ogni popolo o nazione abbia una configurazione spirituale e metafisica unica, di cui la propria cultura è l’espressione».
Invece l’America Latina è un «prototipo del mondo» proprio per le sue differenze, che richiedono risposte su misura, tarate sulle singole situazioni, non grandi narrazioni unificanti.
Il buon selvaggio e il rivoluzionario sono parte dello stesso presepe culturale. Per Mario Vargas Llosa, il tratto più prezioso della cultura occidentale e, in fin dei conti, della civiltà è il perenne rinnovarsi delle idee, «la costante assimilazione di valori e di principî importati che arricchiscono quelli propri». Voler ricondurre a tutti i costi la diversità all’unità è il modo migliore per farsi male.
Sudamerica immaginato, di Nicola Fano, «succedeoggi.it», 15 gennaio 2020.
L’America Latina non esiste. O, meglio, quella vera non esiste per noi europei, abituati come siamo a cercare in quel Continente il paradiso o l’inferno (a seconda delle convenzioni o delle convinzioni). È la teoria di Mario Vargas Llosa (uno che di certe cose se ne intende), espressa in un saggio godibile quanto pignolo, appena pubblicato in italiano dalla piccola ma preziosa casa editrice liberilibri: Sogno e realtà dell’America Latina, pp. 33+XIV, 10 Euro, con un’introduzione di Carlo Nordio. D’altra parte, la faccenda partì male fin dall’inizio: «Cristoforo Colombo – ricorda Vargas Llosa – si sforzò di vedere non quello che era davanti ai suoi occhi e sotto ai suoi piedi, ma l’India, la Cina, l’Asia della seta e delle spezie che portava con sé nel suo desiderio e nella sua immaginazione». E questo, sostiene l’autore della Zia Julia e lo scribacchino o delle Avventure della ragazza cattiva, è il destino amaro di quel Continente: incarnare sogni e desideri non propri.
Mario Vargas Llosa – con la civetteria polemica che gli è propria – fa un lungo elenco di avventurieri e colonizzatori della prima ora che non videro ciò che videro ma ciò che sognavano (o temevano): «Questa inclinazione a idealizzare l’America, proiettando nelle sue selve, cordigliere, altipiani e mari le favole e le leggende più antiche e i luoghi e i popoli dell’immaginazione, non era esclusiva della gente colta: veniva infatti condivisa dagli europei più umili». Il punto è tutto qui: l’America Latina non è stata soltanto colonizzata nel senso materiale del termine, ma le è stata rubata la vera identità. Al punto che sovente gli stessi americani hanno creduto di essere altro da sé: «l’Europa proietterà spesso sull’America le utopie, le frustrazioni artistiche e ideologiche (anche religiose) nate nel suo seno e condannate laggiù, a vivere confinate nei regni dell’illusione». In pratica: gli europei hanno dato corso in America Latina ai propri fantasmi, concedendosi nel nuovo Continente ciò che si vietavano nel Vecchio. È stata una lunga teoria di infatuazioni fallaci, dai mostri andini a Macondo (Vargas Llosa non fa cenno, ovviamente, all’odiato García Márquez, ma l’ombra dell’entusiasmo globale per il cosiddetto realismo magico pervade sotto traccia queste pagine).
Sono da non perdere, in questa chiave (quella dell’innamoramento fallace) le notazioni dedicate al mito della rivoluzione cubana. Da un lato, Vargas Llosa loda la concretezza dei “rivoluzionari” dall’altra irride la cecità di chi (Günter Grass e Régis Debray sono i più citati) ha confuso il mito con la realtà di una «dittatura che si è guadagnata l’onore di essere la più duratura dell’America Latina» (il saggio è del 2008, ma è improbabile che Vargas Llosa sul tema oggi abbia cambiato idea). Ancora una volta, gli europei finiscono per amare del Sudamerica ciò che mai tollererebbero in casa propria: «Avrebbero mantenuto lo stesso entusiasmo se il subcomandante Marcos avesse cercato di portare a termine la sua “rivoluzione postmoderna”, come venne chiamata da Carlos Fuentes, non nello Yucatan, bensì in Bretagna o in Alvernia?». Naturalmente, Vargas Llosa giustifica i “suoi”: «Incarnare l’immaginazione per l’“altro” ha prodotto un curioso effetto: molti latinoamericani hanno adottato quelle immagini di sé, alterate dalla fantasia o dall’alienazione religiosa e ideologica occidentale e, invece di incarnare la propria realtà, ne hanno creata un’altra in accordo con quei modelli e imiti importati». E così torniamo al punto di partenza.
Insomma, si tratta di un piccolo saggio imperdibile: non solo per la sostanza (sia pure fatta la tara alla proverbiale rabbia dell’autore) ma anche per lo stile (colorato dalla stessa rabbia): il tono è persuasivo ancorché un po’ professorale e ricorda il Vargas Llosa che tentò la carta politica nel suo paese, il Perù, finendo sconfitto da un peruviano acquisito, il giapponese Alberto Fujimori. Il quale portò il suo Paese più a destra di dove voleva portarlo il grande scrittore, per altro. Questo per dire che, benché la politica non sia mai stato suo forte, qui Vargas Llosa compone un’invettiva non solo nella sostanza condivisibile, ma accorata e geniale: una tirata antieuropea educata e motivata (niente a che fare con Trump e Johnson, per intenderci). Solo, resta da chiedersi: ma Vargas Llosa avrebbe scritto le stesse cose due anni dopo? Ossia dopo aver ricevuto dagli odiati/amati europei il Premio Nobel?
La versione di Mughini, di Giampiero Mughini, «Dagospia», 11 gennaio 2020.
Caro Dago, era tempo che spasimavo di dirti l’eccellenza di una roccaforte editoriale del liberismo moderno quale la casa editrice liberilibri di Macerata. Aspettavo l’occasione buona, ossia un libro che tra i tantissimi bei libri da loro pubblicati fosse di tale implacabile urgenza e intelligenza da meritare di essere celebrato nelle poche righe di un mio scritto a te destinato. Ebbene il Sogno e realtà dell’America Latina del premio Nobel Mario Vargas Llosa, un breve saggio del 2009 che funge adesso da numero 142 di una delle più belle collane della casa editrice maceratese, è l’occasione perfetta per farlo.
Trenta sugosissime paginette dello scrittore peruviano che demoliscono senza lasciarne pietra su pietra “le stravaganti imposture” che per almeno mezzo secolo hanno avuto cittadinanza eccome nelle generazioni europee che volgevano a sinistra, quelle generazioni (quorum la mia) che s’erano abbeverate a un famosissimo libro del 1967 di Régis Debray venduto a centinaia di migliaia di copie e dov’era scritto che bisognava “fare come a Cuba”.
Sì, fare a Parigi oppure a Milano oppure ad Amburgo quello che i “barbudos” avevano fatto a Cuba, cacciar via un tirannello indecente e apprestarvi la lotta contro tutte le ingiustizie e le indecenze di una società spaccata tra i pochi “che hanno” e i moltissimi che “non hanno”.
E come se questo presepe da due soldi corrispondesse minimamente alla realtà e alla articolazioni sociali delle moderne società industriali. In Italia questa bandiera è stava sventolata innanzitutto da Giangiacomo Feltrinelli, che giudicava la Sardegna il luogo italiano adatto da cui far partire i guerriglieri e la loro lotta di liberazione. (Resterà uno dei grandi misteri della nostra storia editoriale il caso dell’autobiografia di Fidel Castro alla quale il più bravo redattore della Feltrinelli, Valerio Riva, lavorò per anni e anni e poi non se ne fece niente. Perché? La libreria antiquaria Pontremoli di Milano è di recente entrata in possesso di un giro di bozze del libro tutto annotato da Riva. Inutile aggiungere che mi sono precipitato a comprarlo. E’ un cimelio di tutta una stagione dell’editoria e dell’anima europea.)
A proposito di quelli che si invasarono del mito castrista tanto Vargas Llosa quanto l’ex magistrato Carlo Nordio (intelligente prefatore del libro di cui sto dicendo) accennano sprezzantemente al viaggio di pochi giorni a Cuba che Jean-Paul Sartre _ purtroppo “un cattivo maestro” come pochi altri ce ne sono stati _ fece al tempo dell’invasamento filocastrista di tanti, un viaggio di pochi giorni dal quale lui ne uscì pontificando sulla democrazia di qualità superiore che c’era a Cuba.
Chiacchiere, bugie, falsificazioni indecenti, farneticazioni ideologiche senza alcuna base di fatto. Quella castrista era ed è una dittatura, la più lunga di quelle che hanno avvelenato quest’ultimo mezzo secolo di storia dell’America Latina. Scrive Vargas Llosa: “Vero è che quasi mezzo secolo dopo tali avvenimenti, quella rivoluzione si scolorì e perse il suo splendore paradisiaco per molti europei, incluso lo stesso Régis Debray.
Ma è anche vero che c’è ancora chi, nel Vecchio Continente si ostina a non vedere la realtà così com’è, e chi, come Ignacio Ramonet, direttore di “Le Monde diplomatique”, cantore aulico di Fidel Castro _ e del comandante Hugo Chávez _ continua a promuovere come esemplare una dittatura che si è guadagnata l’onore di essere la più duratura che l’America Latina abbia mai conosciuto e che, molto probabilmente, nessuno di loro accetterebbe nel proprio Paese”.